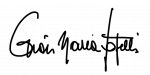Il perdono è un’esperienza che viene connotata soprattutto da una gravitazione religiosa. Forse è l’espressione più emblematica dell’impronta religiosa, che impone alla vita una condizione ineludibile del peccato e di una salvezza possibile ottenibile con il perdono.
Ma il perdono possiede anche una sua traiettoria psichica, che ne fa un’esperienza psichicamente liberatoria, indipendente da un’adesione religiosa o anche etica.
Già nella parola è presente il nucleo che caratterizza il per-dono con la sua vocazione relazionale, di essere un dono all’interno di una relazione.
Essere destinatari di una lesione, di una dimenticanza, di un insulto apre una ferita. Ed è della ferita cercare risarcimento, modi di mitigarne l’emozione di impotenza, di svalorizzazione, di perdita o invisibilità che ha prodotto. Facilmente la ferita trasforma in vittime, partorisce la convinzione di essere stati colpiti da un’ingiustizia, perciò da sottoporre alla sanatoria della giustizia: la condanna. È da questo humus del sentirsi vittima che nasce il perdono, la libertà benevola e nobilitante di astenersi dal volere una pena, per condonarla con un dono.
In questa traiettoria, se il perdono ripristina una stima di sé, lascia però intatta la colpa dell’altro, la sua prepotenza. Si perdona l’altro, si rinuncia a desiderare una punizione, ma rimane immutata la storia psicologica che lo ha reso responsabile della ferita che si è subita. Si perdona con il dono che astiene dalla penitenza, ma si conserva lo status psichico di vittima.
Ovviamente vi sono ferite che non possono essere altro che squarci da rendere vittime. Vi sono accadimenti nei quali non si può fuggire dalla condizione tremenda di vittima. E forse non è neppure sempre benefico il perdono.
Sentirsi una vittima è sempre un’esperienza di annullamento identitario, di perdita di sé. E quando è possibile, e non sempre è possibile, evitare la piega della vittima significa conservare un sentimento della propria integrità.
Non tutte le ferite hanno la stessa devastazione. Ve ne sono verso le quali si può scegliere se sentirsi vittime oppure no, nonostante il disagio o il dolore causato dall’altro. L’essere stati dimenticati, l’insulto che si riceve, le proprie parole fraintese ancorché ferite potrebbero sottrarsi dalla postura della vittima. Non sono così laceranti da non aver avere alternativa al disagio della vittima, del sentirsi prevaricati. Possono essere affrontate con una scelta: se seguirle e farsene avvolgere, sino al sentimento impoverente della vittima, o se sottrarsi al loro lamento, perché più forte è il desiderio di non farsi impadronire dal gesto dell’altro, dal suo sgarbo, dal suo insulto.
Si sente la ferita, si percepisce il disagio di essere stati destinatari di un comportamento mortificante, ma lo sguardo trova qualcosa verso cui guardare che non è la ferita. Trova il desiderio di sapersene stare lontani, di non sentirsi vittime.
Non è più rinuncia alla punizione, non è più benevolenza, ma distacco dall’aggressore, dalla sua violenza, dai suoi errori. Si espelle l’altro e i modi che ha avuto, trovando per il perdono ragioni nel desiderio di sentirsi più forti della ferita. Quando è più forte il desiderio di non soccombere alla ferita e al suo potere di trasformare in vittime il perdono non è più un dono fatto all’altro, è dono fatto a se stessi.
iscriviti alla newletter di ElseWhere clicca qui