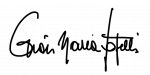Che ne facciamo della nostra fragilità? Della costituzionale debolezza e incompletezza che ci caratterizza come essere umani?
Nella storia civile e sociale dell’uomo è stato uno dei temi più incessanti: elaborare la vulnerabilità. Pur nella diversità dei modi, quasi tutte le differenti civiltà hanno applicato una stessa prospettiva: l’io ha bisogno del noi. Non è stato solo un bisogno di sopravvivenza, la singolarità dell’io veniva definita attraverso il noi. Ogni espressione individuale nella storia dell’uomo è stata ricondotta a radici che trovavano il noi e la sua necessità. Non solo un noi affettivo e parentale, non quello della famiglia, ma un noi comunitario. L’uomo ha sempre considerato la comunità un impegno indispensabile per trarne i confini e il riconoscimento dell’io. Una comunità di doveri e leggi, di responsabilità. Non vi è eroe omerico senza i suoi doveri verso la comunità. Come non vi un’identità senza cittadinanza. L’io trovava se stesso e le sue possibilità nell’appartenenza, non contro di essa.
Poi qualcosa è cambiato, molto. La più recente liquidità esistenziale ha perduto i perimetri, i margini nei quali l’io era ricondotto a una precisa comunità. Si è affermato un io autosufficiente, continuamente chiamato a costituirsi su se stesso e sulla propria completezza. Si è imparata un’identità cosmetica, un’identità da modificare, abbellire e collezionare senza legami con un noi a cui e in cui sentirsi vincolati per potersi riconoscere. Smarrita la comunità il bisogno dell’Altro si è ridotto a gratificazione e completezza emotiva, se non narcisistica. Una relazione che ha trasformato il rapporto con la propria esistenziale fragilità, non più varco verso un noi solidale, legato da valori e leggi a cui riconoscere autorevolezza.
In questa cornice forse si può leggere anche il diffondersi in modo epidemico della depressione, collegata all’esperienza del fallimento e dell’insuccesso. In un clima di costante valutazione individualizza (nelle aziende, ma anche nei social media che accumulano “like”) l’insuccesso, l’errore e il fallimento sono esperienza depressiva. Sottoposti a una valutazione non più contenuta e stemperata in un’appartenenza sociale e comunitaria. Si è soli nel gestire il carico di sicurezza, controllo e affermazione di cui si ha bisogno.
Non si tratta perciò di una depressione conseguente a uno smarrimento di senso. Non è una depressione “filosofica”. E’ una depressione collegata a una mancata affermazione di sé, nella solitudine in cui ci si trova davanti al giudizio dell’altro.
Una depressione che può diventare anche una forma di codardia, quando non si sa elaborare il proprio fallimento, quando si elude e rimuove la responsabilità del proprio insuccesso, dando spazio alla propria ferita narcisistica, senza saper ricondurre alle proprie incapacità o carenze l’insuccesso. Una depressione che rivela l’incapacità ad accettare la propria vulnerabilità e a gestire la fatica di una relazione con sé consapevole dei propri limiti e delle proprie debolezze. Senza il noi della comunità che è contenitore di debolezze, l’io solitario cerca di nascondersele.