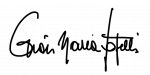Il sentimento di colpa funziona, per quanto possa essere faticoso e doloroso. Funziona per riscattarsi, per riparare e consolarsi delle proprie carenze.
Quando si è di fronte a un fallimento o un errore, a un evento da cui non ci si può dissociare, ma che impone l’evidenza di un proprio sbaglio, di una carenza o un’incapacità di cui si è stati autori, in queste circostanze il cuore, con la sua protettiva assistenza inconscia, cerca di correre ai ripari, cercando di contenere e ridurre il dolore che affligge per la propria insufficienza. Così, quando è ineludibile dover ammettere la propria mancanza, salva il senso di colpa, un sentimento riparatore e farmaceutico.
Sentirsi colpevoli, sebbene disagevole, consente un benefico risanamento. Nel ripiegamento dolente del sentimento di colpa si ottengono provvidenziali vantaggi psicologici.
Sentendosi colpevoli ci si sente protagonisti di ciò che ci è accaduto. Si alimenta il vissuto di sentirsi autori di ciò che si vive, anche se può essere doloroso. “Ho sbagliato io”, “E’ dipeso da me”. Il senso di colpa consente una rassicurazione onnipotente di controllo sulla realtà. Nel momento in cui ammettiamo il fallimento rivendichiamo emotivamente la nostra centralità. Non lasciamo che il fallimento sia un evento che abbiamo subito, impotenti di fronte alla vita. Si può trovare un’analogia con il figlio piccolo di coppie che si separano. Quasi sempre il figlio si sente in colpa, e quindi causa, della separazione dei propri genitori. Non si tratta di una strategia di automortificazione, al contrario di sopravvivenza. Nel sentirsi in colpa, per quanto possa essere doloroso, il figlio conserva una risorsa fondamentale di sopravvivenza: sente di avere il controllo della propria vita; il dramma che sta vivendo non è estraneo alla sua possibilità di determinare la propria vita, può conservare il sentimento di averne un controllo. Il sentimento di colpa riconduce l’ignoto, l’imprevisto e l’inatteso a ciò che si è fatto, a se stessi; proteggendo il bisogno di sentire di avere un effetto e un dominio sulla realtà.
Così non è totalmente innocente il sentimento di colpa, perché con un soccorso inconscio consente di elaborare la convivenza con i nostri errori e le nostre carenze. In altre parole, il sentimento di colpa ha come destinatario principale la riparazione, pur dolorosa, della propria autostima.
Sovente accade anche che il sentimento di colpa sia accompagnato da un sentimento di impotenza, di immobilità. Ci si può sentire protagonisti di quanto accaduto con il sentimento riparatore della colpa e allo stesso tempo accontentarsi del solo sentimento di mortificazione che si vive, quasi bastasse a sancire una nostra eticità.
Ben diverso è il sentimento di responsabilità, che in occasione di una carenza e o di un errore produce un’azione e la volontà di cambiare per non ripeterlo. Meno impegnativa l’autocommiserazione colpevolizzante, a cui si lega un vissuto di dolore ma non lo sforzo, ben più faticoso, di mutare i propri modi di agire, quelli che hanno originato l’evento di cui ci si sente colpevoli.
English